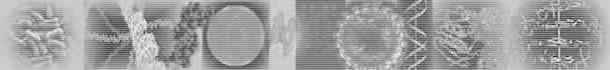Il DNA può annodarsi in diversi modi. Per esempio, una molecola di DNA a doppia elica pùo portare filamenti singoli, tra loro complementari, a entrambe le estremità 3′, cioè può avere terminazioni coesive. E’ il caso del DNA del batteriofago lambda quando il DNA è all’interno del batteriofago. Una molecola di quel tipo diventerà circolare spontaneamente in soluzione o all’interno del batterio quando il lambda DNA è iniettato nella cellula.
Durante il processo di trasformazione cacasuale del DNA lineare in un circolo chiuso, la molecola che ne risulta può mostrare di non essere annodata o di essere annodata in modi diversi.
La probabilità di annodarsi dipende dalla lunghezza del DNA e dal diametro effettivo del DNA. Il diametro effettivo del DNA può essere significativamente maggiore del suo diametro geometrico a causa della repulsione elettrostatica tra due segmenti di DNA in avvicinamento, ciascuno dei quali è fortemente carico negativamente. Questa repulsione elettrostatica è schermata da piccoli ioni positivi in soluzione o all’interno della cellula (Ioni Na). Tanto maggiore sarà la concentrazione di ioni Sodio, tanto più il diametro effettivo si avvicina al suo valore minimo geometrico 2 nm.
La probabilità di annodamento del DNA è stata calcolata accuratamente (Frank-Kamenetskii et al., 1975; Klenin et al., 1988) e questi calcoli sono stati pienamente confermati da misure sperimentali Della frazione di DNA annodato, in soluzioni a diverse concentrazioni di sodio (Rybenkov et al., 1993; Shaw e Wang, 1993). Poichè la trasformazione del DNA lineare in un circolo chiuso con estremità coesive avviene effettivamente in caso di infezione da parte di alcuni batteriofagi (non solo nel caso del fago lambda), la probabilità consistente, prevista teoricamente, di formazione di nodi, ha suggerito che deve esistere un particolare meccanismo in grado di intervenire nella topologia del DNA (Frank-Kamenetskii et al., 1975): Le DNA-Topoisomerasi di tipo II hanno dimostrato di essere enzimi in grado di stringere e di sciogliere i nodi del DNA (Liu et al., 1980; Wang, 1996).
Tags:
DNA,
forme-dna,
nodi,
topologia
Il DNA è il principio trasformante
Il DNA è stato scoperto nel 1953 dai dottori Watson e Crick, ma già nel 1928 esperimenti condotti dal dottor Griffith scoprirono che vi fosse l’esistenza di una molecola capace di trasformare geneticamente gli elementi;
Il principio trasformante
L’esperimento del dottor Griffith fu:
“aveva un batterio, lo pneumococco, del quale si distinguevano due ceppi, S che provocava polmonite quindi morte, R non virulento. Questi due tipi di ceppi vennero inoculati in un certo ordine provocando dei risultati.”

I risultati sono i seguenti:
- ceppo S -> topo morto;
- ceppo R -> topo vivo;
- ceppo S riscaldato (ucciso) -> topo vivo;
- ceppo S riscaldato con ceppo R -> topo morto.
L’ultimo risultato venne spiegato con un altro esperimento dal quale si dedusse che vi era una sostanza nel ceppo S riscaldato capace di modificare la struttura del DNA, e che faceva diventare il ceppo R nocivo.
Con questi esperimenti Griffith dimostrò che il materiale genetico era la sostanza del principio trasformante dei batteri. Erroneamente, come però la stragrande maggioranza degli scienziati suoi contemporanei, riteneva che questa sostanza dovesse essere di natura proteica.
La composizione del DNA
L’esperimento di Alfred D.Hershey e Martha Chase provò definitivamente nel 1953 che il materiale genetico è costituito da DNA e non da proteine. In seguito a questi risultati incontrovertibili anche gli scienziati che avevano criticato l’esperimento di Griffith si convincono dell’importantissimo ruolo biologico del DNA.
La sigla DNA significa acido desossiribonucleico ed è formato da polimeri (molteplici unità chimiche) di monomeri (singole unità chimiche) detti nucleotidi composti da:
- Gruppo fosfato
- Zucchero (pentoso a 5c)
- Base organica (basi azotate)
Il gruppo fosfato è legato allo zucchero da un legame fosfodiesterico (condensazione)
Nel DNA lo zucchero è il desossiribosio che in 2’ ha un gruppo enolico, mentre nell’RNA è il ribosio. Nello zucchero le posizioni 3’ 5’ sono i punti di legame con i nucleotidi precedenti e successivi, in posizione 1 è attaccata la base azotata.
Le basi azotate si distinguono in due classi:
- Purine, 2 anelli azoto-carbonio, l’azoto è sempre nella stessa posizione ( 9′ 3’ 1’ 7’), e sono:
- Adenina, in 6’ c’è un gruppo chetonico CO
- Guanina, in 6’ c’è un gruppo amminico NH2
- Pirimidine, 1 anello azoto-carbonio, lo zucchero si lega su 1, sono:
- Citosina, 5’ gruppo amminico e assenza di gruppo metile CH3 in 1’ o 5’
- Timina, 5’ gruppo chetonico
- Uracile, manca gruppo metile in 1’ o 5’
L’adenina, guanina e citosina le ritroviamo sia nel DNA sia nell’RNA, l’ uracile solo nell’RNA. Le basi azotate si strutturano in una doppia elica, due filamenti polinucleotidi associati che si avvolgono l’uno all’altro. Posizionate all’interno della struttura, all’ esterno c’è uno scheletro zucchero-fosfato.
Le basi azotate hanno delle regole (regole di Chagaff) precise per la loro strutturazione:
- Complementarietà, o adiacenza, adenina fronteggia timina e guanina la citosina perché vi sono problemi di dimensione in caso dovessimo invertire le posizioni; le basi infatti sono tenute insieme da legami a idrogeno differenti (2 per le prime, 3 per le seconde) che potrebbero modificare la stabilita della molecola di DNA
- Le purine sono più grandi delle pirimidine
- Contenuto di nucleotidi uguale nelle due categorie di basi azotate
Il nucleoside è una parte del nucleotide che comprende lo zucchero + la base azotata.
Entrambi hanno una nomenclatura appropriata: per esempio per i secondi si aggiunge il suffisso –ato .
Le forme del DNA
Esistono diverse isoforme del DNA in funzione della loro idratazione e situazione fisiologica/in-vitro in cui si trovano.

— Forma B:
destrosa ,10 basi per giro;
distanza base-asse 0,34 mm;
asse principale perpendicolare all’asse delle basi
filamenti antiparalleli (entrambe le direzioni 5’gr fosfato-3’gr ossidrilico)
solco minore e maggiore, nell’ultimo ci sono molecole per passaggi/contatti con altre cellule— Forma A: con scarsa umidità, sinistrosa, asse principale + inclinato, 11basi per giro
— Forma Z: sinistrosa, forma a zig zag per alternanza di purine e pirimdine
— Tripla elica: prodotta in laboratorio
La molecola del DNA è molto lunga, fino a qualche metro, e viene raggomitolata come un rocchetto da specifiche proteine.
La denaturazione del DNA, cioè lo svolgimento e la separazione dei filamenti che è chiamata anche fusione è un processo importante perché rende possibile la trascrizione attraverso il mRNA. La fusione è causata da un incremento di calore (in laboratorio) capace di rompere i legami idrogeno e le altre forze stabilizzanti il DNA, come legami tra basi adiacenti di uno stesso filamento.
La fusione modifica l’assorbanza della luce, misura direttamente proporzionale alla concentrazione del DNA.
Tags:
composizione-dna,
DNA,
forme-dna,
principio-trasformante