Può la Scienza arrivare a conoscere tutto?
 E’ stupefacente pensare ad un cervello che si stupisce pensando a se stesso, eppure è esattamente ciò che sta succedendo in questo momento, mentre i miei neuroni comandano alle mie mani di scrivervi. Questo stupore è la molla che mi spinge ad orientare anche i vostri pensieri, cari i miei lettori, ponendo quindi le premesse per la creazione di una rete di cervelli increduli di fronte al pensiero di se stessi. La complessità del nostro universo è arrivata ad un punto tale che una porzione ben strutturata di materia (il mio cervello così come i vostri, appunto), può generare un gioco di scatole cinesi di questo tipo, in modo puramente astratto… ed ovviamente noi umani non ci limitiamo a questo: lo sanno bene i neurobiologi, che ogni giorno si alzano la mattina e sanno che sarà una corsa durissima, essendo il loro obiettivo davvero difficile: capire (con i loro cervelli) quali siano le basi molecolari e cellulari che consentono ad una rete di neuroni di partorire fenomeni straordinari quali la memoria, la capacità di astrazione, l’autocoscienza. Ma fino a che punto può spingersi la nostra conoscenza del cervello umano? Ci sono dei limiti invalicabili? La risposta è sì. E se leggerete oltre, vedremo insieme come questa semplice domanda apra una serie di prospettive notevoli sulla conoscenza dell’intero Universo.
E’ stupefacente pensare ad un cervello che si stupisce pensando a se stesso, eppure è esattamente ciò che sta succedendo in questo momento, mentre i miei neuroni comandano alle mie mani di scrivervi. Questo stupore è la molla che mi spinge ad orientare anche i vostri pensieri, cari i miei lettori, ponendo quindi le premesse per la creazione di una rete di cervelli increduli di fronte al pensiero di se stessi. La complessità del nostro universo è arrivata ad un punto tale che una porzione ben strutturata di materia (il mio cervello così come i vostri, appunto), può generare un gioco di scatole cinesi di questo tipo, in modo puramente astratto… ed ovviamente noi umani non ci limitiamo a questo: lo sanno bene i neurobiologi, che ogni giorno si alzano la mattina e sanno che sarà una corsa durissima, essendo il loro obiettivo davvero difficile: capire (con i loro cervelli) quali siano le basi molecolari e cellulari che consentono ad una rete di neuroni di partorire fenomeni straordinari quali la memoria, la capacità di astrazione, l’autocoscienza. Ma fino a che punto può spingersi la nostra conoscenza del cervello umano? Ci sono dei limiti invalicabili? La risposta è sì. E se leggerete oltre, vedremo insieme come questa semplice domanda apra una serie di prospettive notevoli sulla conoscenza dell’intero Universo.
L’unico modo per conoscere in modo completo un certo sistema è avere piena consapevolezza dello stato in cui le sue componenti elementari (ovvero gli atomi, con i loro nuclei ed elettroni) si trovano: ma gli atomi che compongono la nostra materia grigia sono talmente tanti, che è impossibile per il cervello stesso immagazzinare così tanta informazione. Pensateci bene: si arriverebbe facilmente al paradosso che un cervello, per contenere tutta questa mole di dati, dovrebbe essere più grande di sé. Bene, allora potremmo pensare che, in un futuro lontano, l’intero universo sarà pieno di migliaia di miliardi di uomini distribuiti su tanti diversi pianeti orbitanti attorno a stelle di galassie diverse; beh, miliardi e miliardi di cervelli potranno mettere insieme le proprie forze e contenere tutta l’informazione necessaria per definire lo stato di tutte le particelle che compongono un (ed un solo) cervello umano in un certo momento! Qualcuno qui obietterà che avremmo potuto più semplicemente progettare e costruire un computer sufficientemente potente per raggiungere il medesimo obiettivo, senza necessità alcuna di scomodare l’intero genere umano. Benissimo, sono d’accordo… ma se invece volessimo immagazzinare in un computer tutta l’informazione per conoscere appieno ogni minimo dettaglio dell’Universo, cosa dovremmo fare? Come avrete già capito, ci troviamo ancora di fronte ad un paradosso,* peraltro più grande del precedente: avremmo bisogno di un computer più grande dell’Universo stesso! Cari lettori, pur credendo ciecamente nelle capacità del pensiero razionale, devo confidarvi che la Scienza non permetterà mai di raggiungere la conoscenza assoluta della Natura e dell’Universo. Con buona pace di Stephen Hawking.
* Nell’universo de “la Fondazione” di quel genio di Isaac Asimov, un suo personaggio dimostra come sia possibile studiare in dettaglio l’universo (ed effettuare previsioni sul comportamento dei sistemi che contiene) utilizzando un modello meno complesso dell’Universo stesso. Questo lo porta a proporre una serie di equazioni che consentono di predire il comportamento dell’umanità nel suo insieme, ed il futuro svolgimento della storia. Forse, è meglio che questa sia fantascienza… altrimenti addio superenalotto (tra le altre cose).
Tag:astrazione, cervello, coscienza, Isaac Asimov, neurobiologia, neuroni, pensiero razionale, rete, rete di neuroni, scatole cinesi, Stephen Hawking, universo
seguici anche su Facebook!
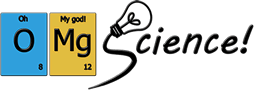

Mah, analisi superficiale, che ignora il fatto che non è necessario immagazzinare tutta l’informazione ed elaborarla in tempo reale, per poter conoscere l’evoluzione di un sistema, considerando che molti dati sono ridondanti e quindi basta replicare un certo n numero di volte quei parametri e prendersi il tempo giusto, vedi ad esempio le potenzialità, nel descrivere proprietà fisiche della materia,anche complesse, come le strutture caotiche delle nuvole o del DNA dell’escherichia coli, della geometria frattale. Comunque la questio è aperta, e non si può di certo esaurire in un commento. Caro Pepito, non hai fatto i conti con don Camillo.
E’ difficile dire a priori cosa sia davvero ridondante. A livello “macroscopico”, sono d’accordo con te. Ma se su scale piu’ ridotte sbaglio a descrivere anche di pochissimo le forze che stanno agendo su un ramo pericolante dell’albero sotto cui Newton sta riposando, allora Newton potrebbe non sopravvivere alla caduta del suddetto ramo nel mio modello (che è comunque necessariamente approssimanto, in quanto modello). Peccato che Newton non sia morto sotto un ramo, ed abbia invece visto la mela cadere ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Insieme_di_Mandelbrot
Questo frattale è, nel suo insieme, incredibilmente complesso, eppure, l’equazione che lo descrive è semplicissima, ed è dotato di una infinità (letterale)di dettagli, ciononostante può essere realizzato su di un computerino senza grandi pretese nè di potenza elaborativa nè di memoria. Quello che descrivi tu, e cioè di come la variazione di un dettaglio minimo, microscopico, cambi lo stato macroscpico, è già stato preso in cosiderazione, e si chiama butterfly-effect http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_farfalla fenomeno controverso trattato nella più ampia “teoria del caos”, che è una delle più grandi sfide della scienza del 21° secolo, ed i frattali avranno di sicuro un ruolo fondamentale.
http://www.dti.unimi.it/~pizzi/TESI_ECG/1%20Teoria%20del%20caos.pdf
Considerando, quindi che il cervello, è sì complesso, ma poco caotico, ha un elevato livello di ordine, non potrebbe essere altrimenti, in caso contrario sarebbe difficile immaginare un suo corretto funzionamento, credo che una sua descrizione sia alla nostra portata, è solo questione di tempo.
La scienza è strumento incredibilmente potente, può fornire rispote che talvolta neanche noi ci aspettiamo, abbiate fiducia (non fede, fiducia) in essa.
Caro Michele,
voglio sgombrare il campo dai dubbi:
sono anche io molto fiducioso, diciamo certo, che si riuscirà prima o poi ad ottenere un modello affidabile del funzionamento del cervello. Il mio articolo però si pone un problema diverso (anche se effettivamente parto dal cervello nella mia discussione, ma faccio questo giusto per coinvolgere il lettore in un esperimento mentale il piu’ possibile coinvolgente)… il problema che mi pongo è: può la scienza arrivare a conoscere ogni minimo dettaglio dell’Universo? E la risposta è, no. A tuo avviso, i dettagli che non possiamo conoscere sono irrilevanti; a mio avviso, non lo sono. La differenza tra i nostri punti di vista credo si riduca a questo.
“E la risposta è, no.” mmmh, piuttosto perentorio ed assolutista, senza neanche dare un straccio di spiegazione. Quali sarebbero questi quesiti invalicabili per la scienza?? Chi è Dio? Se esiste? Perchè esistiamo? Ebbene, voglio proprio sbilanciarmi, ad ognuno di questi quesiti, una risposta, anche se embrionale c’è già, e si trova tra le pieghe delle equazioni della meccanica quantistica. Solo una cosa però aggiungo, formalmente, quesiti di questo tipo non fanno parte dell’interesse di indagine di quello strumento che chiamiamo scienza, ma, attraverso la descrizione dell’universo da essa fornita, emergono, in modo indiretto, altre risposte, che nessuno si aspettava. Questa teoria pur essendo una descrizione incompleta dell’universo, in quanto limitata a fenomeni microscopici, attraverso le sue incredibili e tavolta stravaganti (ma vere, sperimentalmente vere) conclusioni, ci sussurra, quasi sottovoce le verità ultime, che l’uomo da sempre cerca. Naturalmente, una teoria nuova, una “teoria del tutto” che unisca relatività e meccanica quantistica, di sicuro potrà meglio confermare quanto oggi è ancora speculazione, anche se matematicamente dimostrata. Leggi questo interessante articolo di John Wheeler, il fisico che coniò il termine di “buco nero” per le stelle infinitamente collassate previste dalla teoria della relatività generale, e che ebbe tra i suoi allievi gente del calibro di Richard Feynman, Hugh Everett III, Kip Thorne e James Hartle.
http://discovermagazine.com/2002/jun/featuniverse
Probabilmete ti chiederai “ma se queste verità sono svelate, per quale ragione non vengono divulgate?” Perchè sono difficili da comprendere, occorre una robusta preparazione matematica, ma sopratutto sconvolgenti nella loro banalità, e quindi difficili da accettare.
Di seguito riporto alcuni link che descrivono teorie del tutto in “embrione”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity
http://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Supergravity
Non potevo far mancare un’interessantissima interpretazione, diciamo non ortodossa, della meccanica quantistica:
http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
Molto interessante,
aggiungerei che oltre ad un limite quantitativo (il volume dell’informazione da gestire) sussiste un limite, come dire, strutturale.
Considerando il cervello in termini puramente meccanicistici, il cervello è una macchina elettrochimica con una particolare configurazione, seppur enormemente complessa, di circuiti. L’attivazione di tali circuiti, per quello che ne sappiamo, produce i pensieri.
Alcuni pensieri ci sono preclusi perchè il nostro cervello non possiede le strutture per elaborarli: per esempio possiamo formalizzare l’associazione di un colore ad un suono, o possiamo scrivere scrivere numeri arbitrariamente grandi ripetendo una successione di pochi simboli cui singolarmente siamo capaci di attribuire un valore, ma non esiste una struttura logica per cui necessariamente siamo un grado di cogliere l’inevitabile connessione tra il numero 3 ed una determinata frequenza di colore, o la quantià 987613287561389754318473234873428715238 che pure possiamo scrivere.
E tutto questo è cmq ancora in qualche modo formalizzabile, tutto cio’ che è assolutamente inconcepibile (e per definizione non posso portarne esempi) rimarrà sempre al di fuori del nostro orizzonte di conoscenza e forse non saremo nemmeno in grado di coglierne l’esistenza.
Aggiungo anche che nel particolarissimo caso che il nostro cervello sia una macchina di potenza tale da gestire tutta l’informazione realmente esistente non puo’ essere una macchina di potenza infinita, perchè pur giunti a conoscere tutto potrebbe sempre ipotizzare che ci sia qualcosa che strutturalmente ci sfugge.
E sostenere che il cervello (o la mente, o la capacità proiettiva della mente umana) sia infinità, purtroppo per Hawking manca del principio fondamentale della scientificità, ovvero, la falsificabilità.
Ma che la mente umana abbia dei limiti non lo metto in dubbio, qui però parliamo di scienza che è uno strumento che l’uomo utilizza proprio per sopperire a tali limitazioni. Quegli esempi che Andrea ha citato sono limiti della mente umana, come nel caso dell’associazione tra colore e suono, la scienza ci permette di capire che entrambi, sono fenomeni ondulatori, elettromagnetico il primo, meccanico il secondo, riuscendo così a cogliere un’accomunaza altrimenti non percepibile dall’uomo. Quindi il problema non è capire se il cervello può comprendere se stesso ma se la scienza può capire il cervello. La scienza crea modelli semplificati per descrivere la realtà, ma pur nella semplificazione tali modelli risultano incredibilmente efficaci. La meccanica quantistica, ad esempio, fornisce in un sol colpo una spiegazione di tutta la chimica, reattività, legami, strutture, proprietà fisiche, e con un modello matematico “semplicissimo” praticamente 2 sole equazioni, che naturalmente vanno sviluppate ed elaborate, ma nulla di impossibile, considerando la mole di spiegazioni che fornisce. La mente (e qui ci sarebbe da fare una distinzione tra il dualismo mente-software e cervello-hardware, e ci vorrebbe altro tempo) sarà miope, ma la scienza è la sua lente. Comunque consiglio, se non l’avete già fatto, un paio di letture, assai interessanti, di un autore, che parla proprio di agomenti di questo tipo, si tratta di Paul Davies, i titoli sono: “La mente di Dio”, e “Dio e la nouva fisica”, io li ho trovati illuminanti. Saluti.
caro michele,
nella tua considerazione pero’ trascuri che la scienza è frutto del cervello (o dell’insieme dei cervelli che la elaborano).
Ed essendo, a mio aprere almeno, il cervello una macchina limitata (nel senso anche semplicemente di limitata, per numero di atomi che la compongono, numero e tipologia di connessioni) non puo’ giungere ad elaborare cose che esulano dalla sua capacità di calcolo (non intesa tanto in senso quantitativo, quanto piuttosto qualitativo).
Tu citi la meccaanica quantistica, ma la meccanica quantistica non offre una conoscenza assoluta, nemmeno di tutta la chimica, la reattività di legami eccetera…
E non lo dico io.
Lo dicono il principio di indeterminazione
e i teoremi dell’incompletezza di godel.
La scienza, intesa come formalizzazione/modellizzazione verificabile di un modello è limitata perchè è limitata la struttura (cervello) che ‘crea’ la scienza.
E anche ipotizzando che la nostra macchina neurale crea-scienza agisca perfettamente al massimo potrà giungere a cogliere parte della propria limitatezza (ma non potrà comunque coglierla completamente, cio’ perchè prevederebbe una sovrastruttura a se stessa).
Già adesso sappiamo che ogni teoria scientifica che abbia la forza espressiva della matematica è incompleta, e già adesso sappiamo che non è possibile misurare con infinita precisione parametri legati dal principio di indeterminazione.
Quindi già adesso sappiamo che la scienza non puo’ giungere a cogliere il tutto.
Andrea